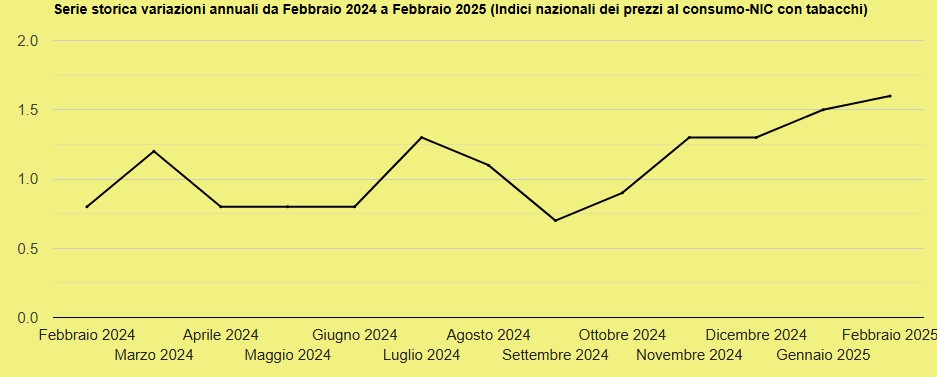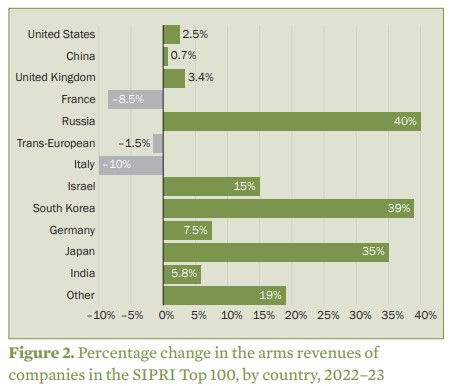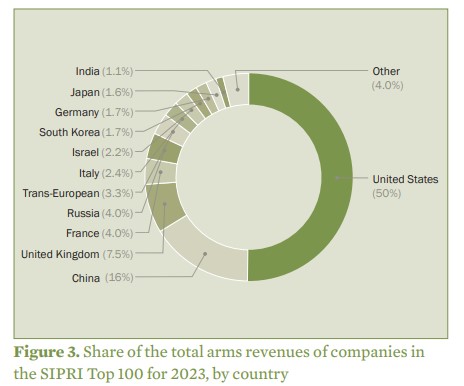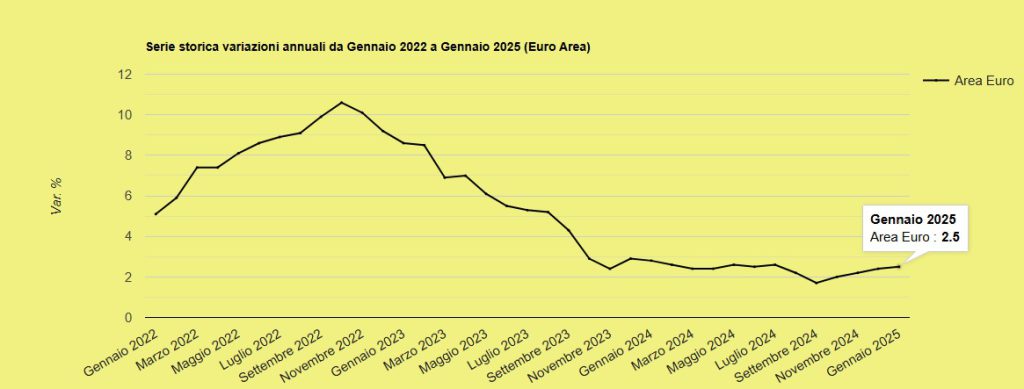Cos’è l’Euribor

Euribor (Euro Interbank Offered Rate) è un tasso di interesse di riferimento che indica quanto costa mediamente prendere a prestito denaro tra banche europee senza garanzie. Il marchio “Euribor” è registrato ed è di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute), l’organizzazione con sede a Bruxelles che ne gestisce regolamento e supervisione.
Chi calcola l’euribor
Sebbene EMMI sia l’amministratore ufficiale del benchmark Euribor, il calcolo giornaliero viene effettuato da un soggetto terzo indipendente chiamato calculation agent: si tratta di Global Rate Set Systems Ltd (GRSS).
- GRSS raccoglie i dati inviati dalle banche del panel ogni mattina.
- Applica le regole del metodo ibrido definite da EMMI.
- Calcola i tassi ufficiali escludendo i valori estremi e facendo la media aritmetica semplice.
- Pubblica i valori tramite EMMI e provider come Bloomberg e Reuters.
Perché il calcolo dell’Euribor è affidato a un soggetto terzo?
Il motivo principale è evitare conflitti di interesse e garantire neutralità operativa. EMMI, in quanto amministratore del benchmark, definisce il metodo e supervisiona il processo, ma non esegue materialmente i calcoli.
Affidare il calcolo a un calculation agent indipendente serve a:
-
✅ Rendere il processo imparziale: il calculation agent non ha interessi finanziari diretti nel valore del tasso.
-
✅ Separare la supervisione dal calcolo: EMMI controlla, ma non esegue.
-
✅ Garantire integrità tecnica e sicurezza informatica: il soggetto terzo è specializzato in infrastrutture critiche, cifratura dei dati e trasmissione sicura.
-
✅ Aderire alla normativa europea (BMR): è una precisa richiesta regolamentare.
Chi impone questa separazione dei ruoli?
La separazione tra amministratore e calculation agent è imposta dal:
🔷 Regolamento UE 2016/1011 (BMR – Benchmark Regulation)
-
Il BMR è entrato in vigore dopo lo scandalo Libor/Euribor del 2011-2012, che ha mostrato come la manipolazione dei tassi fosse possibile proprio perché le banche potevano influenzare direttamente i valori senza controlli terzi.
-
Il BMR richiede che l’amministratore (EMMI, in questo caso):
-
abbia un sistema robusto di governance,
-
eviti conflitti di interesse,
-
e, ove possibile, affidi l’elaborazione tecnica dei dati a soggetti indipendenti, cioè calculation agents.
📘 Fonte normativa:
Articolo 5, comma 3, Regolamento (UE) 2016/1011:
“L’amministratore deve assicurare che la funzione di determinazione del valore del benchmark sia separata funzionalmente dalla funzione di supervisione.”
Metodo di calcolo
I tre livelli del metodo ibrido spiegati con esempi concreti
Il calcolo dell’Euribor, sotto la supervisione di EMMI, si basa su un metodo a tre livelli. Questo schema a livelli serve a garantire che, anche quando il mercato è poco liquido o fermo, il tasso possa essere comunque calcolato con criteri affidabili.
Le banche del panel comunicano ogni giorno il tasso a cui presterebbero denaro per varie scadenze (1 sett, 1-3-6-12 mesi), utilizzando uno dei tre livelli ammessi dal regolamento. Vediamoli uno per uno.
✅ Livello 1 – Transazioni reali
Significato: La banca ha realmente effettuato un prestito non garantito (senza collaterale) sul mercato interbancario.
🔍 Esempio:
-
La Banca Alfa ha prestato ieri 100 milioni di euro alla Banca Beta per 3 mesi, senza chiedere nessuna garanzia, al tasso del 3,14%.
-
Questo è un dato reale, oggettivo, frutto di una vera transazione.
-
La Banca Alfa comunica 3,14% come contributo Euribor a 3 mesi basato su Livello 1.
🎯 È il tipo di contributo più robusto e trasparente, perché si basa sul prezzo reale di mercato.
🟨 Livello 2 – Dati analoghi corretti tramite modelli
Significato: La banca non ha fatto prestiti non garantiti, ma ha fatto operazioni simili (es. con garanzie) e applica una correzione matematica tramite un modello interno per stimare il tasso che avrebbe applicato senza garanzie.
💡 Cos’è un REPO?
REPO significa “Repurchase Agreement”, ovvero “operazione di pronti contro termine”.
In pratica è un prestito garantito da titoli:
-
La Banca A presta denaro alla Banca B,
-
in cambio, la Banca B offre come garanzia (collaterale) dei titoli (es. titoli di Stato italiani),
-
con l’impegno di riacquistarli a una data futura (da qui “repurchase”).
Poiché il prestito è garantito, il rischio è minore → il tasso applicato è più basso rispetto a un prestito non garantito.
🔍 Esempio Livello 2:
-
La Banca Gamma non ha effettuato prestiti non garantiti ieri, ma ha fatto un repo da 200 milioni di euro a 3 mesi, garantito da titoli di Stato italiani, al tasso del 3,05%.
-
Utilizza un modello interno che stima: “se il prestito fosse stato non garantito, il tasso sarebbe stato più alto di 0,10%”.
-
Risultato: 3,05% + 0,10% = 3,15%
-
La banca comunica 3,15% come stima corretta → contributo Livello 2
🧠 Questo livello è utile nei mercati poco attivi, ma richiede trasparenza nei modelli usati per la correzione.
🟥 Livello 3 – Expert Judgement
Significato: In mancanza sia di transazioni reali (Livello 1), sia di operazioni simili (Livello 2), la banca può inviare una stima esperta, fatta da un analista o responsabile interno.
Questa stima deve essere motivata, documentata, e basata su:
-
Condizioni di liquidità del mercato
-
Tassi osservati su strumenti correlati
-
Costo medio di raccolta della banca
-
Andamento di altri tassi (Eonia, repo, swap)
🔍 Esempio:
-
La Banca Delta non ha effettuato nessuna operazione interbancaria nelle ultime 24 ore.
-
Non ha dati comparabili da cui derivare una stima (Livello 2).
-
Il suo responsabile della tesoreria, usando modelli interni e osservando le condizioni del mercato, stima che avrebbe prestato denaro a 3 mesi al tasso del 3,13%.
-
Questo valore viene inviato come contributo Livello 3.
🛡️ È il livello meno oggettivo, ma regolato e necessario per garantire continuità del benchmark anche nei momenti di mercato poco attivo.
🧭 Riepilogo in tabella
| 🔢 Livello |
Fonte del tasso |
Attendibilità |
Esempio pratico |
| 1 |
Transazione reale non garantita |
⭐⭐⭐⭐⭐ |
Prestito a 100 mln a 3 mesi al 3,14% |
| 2 |
Operazione simile (es. repo) + correzione |
⭐⭐⭐⭐ |
Repo a 3,05% + 0,10% di aggiustamento = 3,15% |
| 3 |
Stima esperta (expert judgement) |
⭐⭐⭐ |
Nessuna operazione → stima interna al 3,13% |
⚠️ Controlli e trasparenza
Tutte le banche devono documentare il livello utilizzato, con motivazioni e dati a supporto.
Il calculation agent GRSS riceve i contributi, verifica la coerenza, ed eventualmente può scartare valori anomali.
EMMI effettua controlli di qualità e audit periodici per garantire la correttezza del sistema.
Esempio completo di calcolo Euribor
Supponiamo 11 banche che comunicano i seguenti tassi per l’Euribor a 3 mesi:
- 3.08, 3.09, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18
Passo 1: si ordinano i tassi. Passo 2: si eliminano i valori più alto e più basso (15% trimming). Passo 3: si calcola la media dei 9 tassi centrali:
- Somma: 28.17
- Media: 28.17 / 9 = 3,13%
Questo valore viene pubblicato alle 11:00 CET come Euribor ufficiale a 3 mesi.
La truffa delle banche con l’Euribor prima del metodo ibrido: la tecnica
Prima del 2014, l’Euribor era calcolato in modo poco trasparente:
-
Le banche comunicavano liberamente un numero: il tasso al quale “pensavano” di poter prestare denaro sul mercato.
-
Non era obbligatorio basarsi su transazioni reali.
-
Non c’era un calculation agent indipendente.
-
Non c’erano obblighi di tracciabilità o giustificazione.
🎭 Esempio (era pre-BMR)
Il trader della Banca A dice al collega della tesoreria:
“Oggi ho una posizione che guadagna se l’Euribor scende. Fammi inviare un tasso un po’ più basso del reale.”
La banca comunica 2,91% invece di 2,96%, e se lo fanno anche altre, l’Euribor finale scende, generando guadagni milionari su contratti derivati.
Nessuno poteva verificare se quel 2,91% fosse reale o inventato.
🛡️ Come il metodo ibrido blocca la manipolazione
1. Obbligo di usare transazioni reali (Livello 1)
Se la banca ha fatto un prestito reale, non può usare un valore diverso.
➡️ Il dato è oggettivo e verificabile.
2. Se non ha transazioni, deve usare modelli documentati (Livello 2)
Qualsiasi correzione fatta ai tassi derivati da operazioni simili (es. repo) deve essere motivata e giustificabile tramite modelli interni.
3. L’uso del Livello 3 (expert judgement) è limitato, tracciato e monitorato
Ogni stima esperta deve essere:
4. Esclusione dei valori estremi (trimming)
Il metodo scarta il 15% più alto e più basso →
Se una banca prova a inviare un tasso molto distorto per influenzare il calcolo, viene semplicemente esclusa dal computo.
5. Calculation agent indipendente (GRSS)
Nessuna banca, né EMMI, può modificare i dati o il calcolo.
Il sistema è automatico, tracciato, auditabile.
🧠 Esempio moderno: tentativo fallito di manipolazione
-
La Banca X non ha fatto operazioni reali.
-
Prova a inviare un valore falsato di 3,40% usando il Livello 3.
-
Ma:
-
Il valore è anomalo → il calculation agent lo segnala.
-
Viene rimosso per trimming.
-
EMMI riceve un alert per ispezionare la motivazione.
-
Se la banca non può dimostrare la coerenza della stima, scatta una sanzione o viene sospesa dal panel.
Risultato: la banca non ha influenzato l’Euribor e rischia penalità.
🔒 Conclusione
Il metodo ibrido frena la furbizia perché:
-
Obbliga a usare dati reali ogni volta che esistono.
-
Richiede giustificazioni per tutto.
-
Taglia fuori i tassi sospetti dal calcolo.
-
Affida il processo a un operatore neutrale.
-
È costruito per essere resistente agli abusi, proprio sulla base delle frodi passate.
Fonti ufficiali